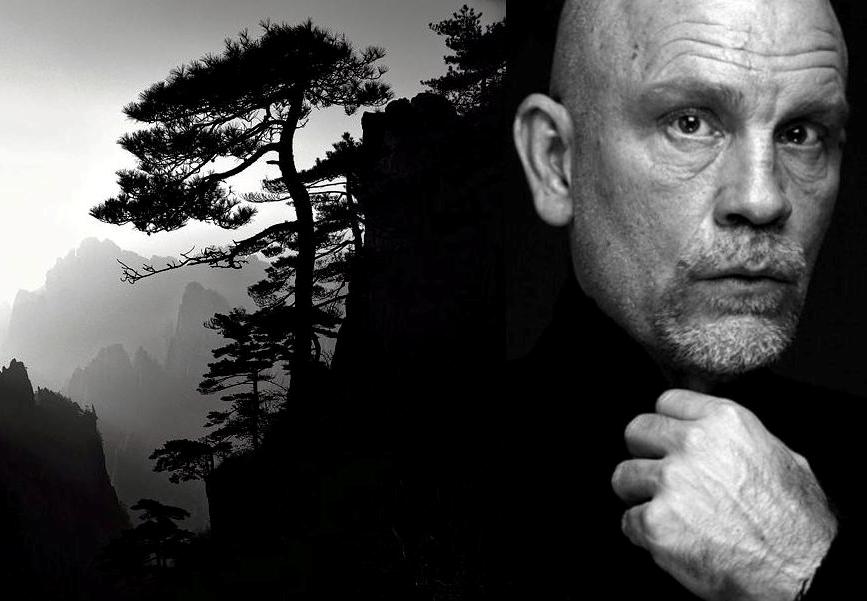Bollata dalla croce instabile a cinque punte, ho
srotolato ogni groviglio nel panteismo primitivo, aborrendo tutte
le mere pratiche idolatriche.
Quelle mefistofeliche, che abbracciano l’albero e baciano la
pietra.
Aggiogata dal torbido preludio, ho braccato l’angolo doppio oltre
le colline tonde, denudate.
Aggrappata al tuo rigido compasso, di colore morello, mi sono
posta ovunque, senza bisogno di piazzarmi dove tutte agognano,
nel centro.
E’ tardi, devo fare in fretta.
Poso il mucchio di diavolini che tengo in mano.
Già pregusto la montagna di rocce sedimentarie e scisti filladici
neri che mi aspettano.
L’ottuso gigante permeabile dalle spalle larghe, acquattato nel
suo nascondiglio di Mesquites alla ricerca bramosa, attraverso
moine e pantomime, di suscitare una soap opera senza puntata.
Per strategia beffarda ti accordo lo spartito, ma rimango a
togliere rulli rossi e gialli, per buttarli nel gran
contenitore.
Anche stavolta, con un’enorme spirale bicolore, digiunerò fino a
quando l’ultimo morso spingerà la forza del fiato.
Per adempiere allo sforzo della caduta, nel suo cessare
d’essere.
So già che la cena sarà sempre la solita.
Stesa con sintassi corretta ed esibita nel monogramma di un
tovagliolo senza una piega.
Zuppa con panna montata a galla, e fettona di carne rossa.
Per dessert: mousse di gelatina molle vischiosa glacé, servita
sulla solita foglia di adamitico fico.
Tutto bagnato da cerchi concentrici di vino nero, d’origine
controllata e certa; garantita.
Ma nonostante la lacca delle congetture, i miei capelli non ne
vogliono sapere.
Per fortuna il mio esistere ultimo-stile inizia a cantare, con la
perla patinata nella gola che modella un tuono.
La mia tiroide sboccia, i boccoli ricadono a zampilli, come una
fontana.
La chioma si ristabilisce.