L' ARCHIVIO DELLE RECENSIONI
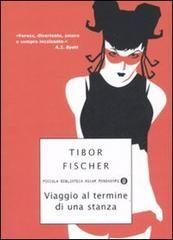
L' ARCHIVIO DELLE RECENSIONI
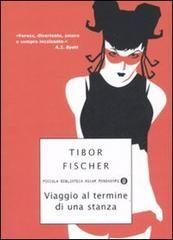
L' ARCHIVIO DEGLI ARTICOLI
Una precisazione importante per i lettori. Mentre l’archivio delle recensioni conterrà quasi tutte quelle che ho scritto nel corso degli anni per il blog lacantinadeilibri, l’archivio degli articoli riporterà solo una selezione dei pezzi destinati ai miei “defunti” blog di politica e costume. Ho deciso infatti di lasciare nella 'naftalina' telematica quelli troppo legati all’attualità, soprattutto politica, del momento in cui “videro la luce”.
Giugno 2017
La scimmia chic
“Dov’era alle diciotto?” “In camera mia. Con mia moglie e con Bachtin, Estetica e romanzo” Sarcastico: ”Presumo che lei l’abbia letto” “No” replicò neutro Bagioli “ però ho visto il film …” Hans Tuzzi, Fuorché l’onore.
E’ mai possibile gioire, da italiani, per la vittoria all’ultimo Eurovision Song Contest di una canzone lusitana di anestetica tediosità e per la contemporanea sconfitta di un pezzo tricolore vivace, ballabile e per nulla banale, al di là delle stesse intenzioni dei suoi autori, come Occidentali’s Karma di Gabbani? In Italia sì, in Italia è possibile, essendo la Penisola da sempre la patria elettiva dei patiti di film cecoslovacchi con sottotitoli in tedesco di fantozziana memoria.
Al di là dello sgarbo alla bandiera, che in tempo di guerra fino a poco tempo fa sarebbe stato passibile di fucilazione (si scherza, suvvia), stupisce lo stomaco dell’affollata tribù delle scimmie chic, capace di trangugiare senza battere ciglio libri, film e musiche al cospetto dei quali la Kotionkin del buon ragionier Ugo appare un capolavoro di plautina scurrilità, un festival di rutti e peti in grado di far sganasciare dalle risate intere legioni di carrettieri.
Diceva Leonardo Sciascia (non proprio Pitigrilli, dunque) che il cretino di sinistra ha una spiccata tendenza verso tutto ciò che è difficile, perché crede che la difficoltà sia profondità. Ora, detta da un intellettuale della statura di Sciascia, grande appassionato dell’illuminismo francese e autore di saggi raffinatissimi, questa frase avrebbe dovuto spedire a Canossa interi reggimenti di scienziati, giornalisti, scrittori, cineasti, sceneggiatori, autori e registi teatrali spocchiosi e supponenti che da decenni, tramandandosi il testimone da una generazione all’altra e con l’appoggio delle truppe cammellate di certa pubblica opinione progressista, ci bombardano i neuroni col messaggio che romanzi, film, canzoni e opere teatrali devono essere obbligatoriamente dei degni sostituti del Roipnol per ottenere il sigillo di qualità.
La deriva sciccosa della cultura di sinistra è iniziata, si sa, con le avanguardie del primo novecento. Fino all’avvento del decandentismo gli scrittori e i poeti, forti della lezione manzoniana, avevano sfornato prodotti solitamente intellegibili a tutti, in teoria anche a chi a malapena sapeva leggere e scrivere. Basti pensare alla fervida stagione del verismo e agli scritti di un Giovanni Verga.
E’ con gli epigoni di Huysmans che si spezza il rapporto tra letterato e popolo, perché il primo ritiene di appartenere ad una koinè di passioni e sensibilità profondamente diversa, distante e migliore di quella a cui viene iscritta d’ufficio l’indistinta massa degli altri individui. L’intellettuale si chiude nella torre d’avorio della ricerca estetica fine a se stessa, del compiacimento adonico della propria creatività, e tutti gli altri diventano “gli schiavi ubriachi” che minacciano la bellezza e contro i quali si scaglia il Claudio Cantelmo della Vergine delle rocce di Gabriele D’Annunzio.
Lo stesso fenomeno di involuzione criptica del messaggio artistico si verificherà nelle arti figurative, passando dall’icastico realismo di ritrattisti e paesaggisti come Hayez, Signorini, Lega, alle risse in galleria di Boccioni, ai dinamismi cinofili di Balla e alle geometrie schizofreniche di Fortunato Depero. Per non parlare delle parole in libertà di Marinetti o delle fontane malate di Palazzeschi.
L’elitarismo culturale del primo novecento è comunque un fenomeno di rottura notoriamente e prevalentemente collocato a destra, la sinistra ne sarà contagiata soltanto dopo il contatto con il dadaismo e con l’espressionismo tedesco e russo. Il distacco definitivo dell’intellighenzia di matrice social-comunista da tutto ciò che, spregiativamente, sarà poi bollato con il derisorio epiteto di “nazional-popolare” (con la salutare eccezione delle feste dell’Unità, pantagruelica rivincita dell’unto e bisunto operaio e contadino sulle sofisticherie – mentali e gastronomiche – della borghesia radicaleggiante dei salotti romani e milanesi), si consumerà però definitivamente soltanto con il secondo dopoguerra: in fumose cantine si cominceranno a rappresentare drammaturghi (Jonesco, Beckett, Pinter, per citare i più noti) e opere totalmente inaccessibili alla casalinga di Voghera e al suo gentile consorte; nelle pittura e nella scultura, la furia sperimentalista approderà alle tele tagliate e alle merde d’artista mentre in letteratura quella iconoclasta dei giovani autori del Gruppo 63 manderà in soffitta il neorealismo dei Cassola, dei Pratolini e dei Bassani, tutti sardonicamente etichettati come Liale al maschile, per proporre tematiche e stili nuovi sì, ma talmente arditi (basti pensare ai romanzi senza trama di Alberto Arbasino) da risultare preclusivi per la stragrande maggioranza dei lettori. La musica da camera, infine, vedrà il trionfo della dodecafonia, una roba che avrebbe trasformato Mozart e Verdi in due assatanati emuli di Jack Torrance, il folle assassino di Shining.
Tutto questo ha alimentato negli anni il mito di una sinistra geneticamente refrattaria, nel mondo delle arti e della comunicazione, ad un apostolato del sapere che prescindesse da chiavi di lettura complesse del “lavoro culturale”(per dirla con Bianciardi), destinate alla fruizione di un pubblico in possesso di elevati livelli di istruzione. Un cerebralismo iniziatico ben rappresentato, più di recente, dai libri del compianto Umberto Eco e che ha condotto la sinistra, nel tempo, a chiudersi in una ridotta della Valtellina poco funzionale alla sua storica missione di garante dei diritti delle masse e di megafono politico dei loro bisogni. Il che ha determinato alla lunga anche una singolare inversione dei ruoli tra l’intellettualità di destra (liberale o populista), votata ad una capillare e intensa attività di divulgazione indirizzata ad una utenza quanto più ampia e variegata possibile, e quella di sinistra, pervicacemente legata ad un modello di trasmissione della conoscenza concepita unicamente come veicolo di idee e nozioni scambiate tra iscritti alla gilda degli edotti.
Non si vuol qui di certo far l’elogio della piattezza, dell’accademia, della faciloneria stilistica e di contenuti. Né, tanto meno, del vero e proprio “pattume” culturale o informativo da cui siamo quotidianamente inondati. Si vuole semplicemente ricordare ai cenacoli intellettuali dell’universo progressista che Totò e Tomas Milian – oggi due icone della critica cinematografica, settore da sempre vicino agli ambienti di sinistra – erano immensi anche quando venivano considerati poco più che guitti da taverna dagli stessi che ora li esaltano e che la canzone di Gabbani non merita certo che si scomodino personaggi come Kant, Shakespeare, Eraclito, Darwin, Karl Marx Desmond Morris o addirittura l’Oswald Spengler de il Tramonto dell’Occidente (ebbene sì, per quanto possa apparire grottesco, c’è stato qualcuno che li ha evocati tutti quanti), ma neppure di essere relegata tra i cloni di Vamos alla playa o del Ballo del qua qua.
Semplicità non sempre fa rima con stupidità, insomma. Senza contare che il Karma di Gabbani di certo lo ballano pure le scimmie chic, mentre il narcotico fado del vincitore del Contest di quest’anno viene ascoltato solo quando una cena importante rende arduo agli umani l’abbraccio con Morfeo.
L' ARCHIVIO DELLE RECENSIONI
L' ARCHIVIO DEGLI ARTICOLI
Agosto 2016
Un Paese sghembo
Città sghemba chiamò Agrigento lo scrittore Vitaliano Brancati (Lettere al Direttore, 1939) e mai definizione si attagliava meglio a quell’angolo di Magna Grecia mollemente sdraiato sul declivio di un colle della Sicilia sudoccidentale. Ma se la Girgenti di Brancati era sghemba per conformazione urbanistica, con strade bozzolute che in certi tratti parevano dorsi di mulo e palazzi che sfidavano le leggi della statica peggio della Torre di Pisa, l’Italia di oggi è sghemba per letale combinato-disposto di nolontà e destino.
Nolontà nel senso datole da Schopenhauer più che da Tommaso d’Aquino. Destino perché la geologia colloca notoriamente la nostra penisola tra i territori più fragili del Continente europeo. Ma se il destino, come ci hanno insegnato greci e latini, non si può contrastare, la nolontà rientra nel novero delle cose passibili di modifica, di svolta, di cambiamento. Purtroppo in Italia, Paese in cui una macedonia tragica di fatalismi, incompetenze, politica, burocrazia e corruzione impedisce da decenni di incidere in profondità nei suoi mali e nei suoi ritardi, la nolontà alla fine riesce sempre a riaffermare il suo predominio. E senza neppure sforzarsi troppo. Il che, fin quando la barca tricolore galleggia comunque, in fondo può anche essere fattore di riso e commedia, spunto per sapide e folcloristiche ricostruzioni del mos nazionale, materia di lavoro per comici e vignettisti.
Il problema emerge in tutta la sua drammatica virulenza quando si contano i morti. Quando si contano i morti, non si può più scherzare. Quando interi borghi vengono spazzati via nel giro di pochi secondi e si tramutano in sudario di dolore e pianto, finisce il cabaret. Quando lo spettatore rischia di confondere il paesaggio dell’alto Lazio con quello della Siria devastata dalla guerra civile, non è più tempo di dotte disquisizioni sul perché e percome. Quando un vigile del fuoco coperto di polvere tira fuori a mani nude una bambina da un inferno di calcinacci, vanno in soffitta articoli, convegni e dibattiti. Quando accade tutto questo, si dovrebbe solo agire e agire significa trovare le risorse e le intelligenze per cambiare il corso degli eventi una volta per tutte. Campa cavallo.
L’Italia intera è un autentico luna-park dell’arte e della cultura che altrove verrebbe presidiato giorno e notte dai reparti speciali dell’esercito peggio di Fort Knox. Noi da anni tolleriamo che crolli, ammuffisca o si sbricioli. Duemila secoli di Storia e civiltà ci hanno lasciato in eredità un museo a cielo aperto pieno di reperti di inestimabile valore che andrebbero preservati, curati, accuditi, controllati. Da tutti perché tutti – tutti gli italiani – dovrebbero essere gli ideali custodi di questo museo. La più insignificante chiesa di campagna di una qualsiasi regione italiana nasconde quasi sempre, al suo interno, un capolavoro: un affresco, una statua, un coro ligneo, un antico organo, una pala d’altare. La più insignificante frazione tra i mille e più campanili che ornano la Penisola ha spesso una peculiarità che la rende unica o comunque attraente: l’amenità del paesaggio, lo stile caratteristico delle abitazioni ecc. Al netto delle chiacchiere da bar o da social network, la politica e la stragrande maggioranza della popolazione italiana sono perfettamente adiafore a tutto questo. Se non lo fossero, se avessimo un minimo di sensibilità (non dico amore, parola sempre troppo impegnativa) verso la Bellezza che ci circonda, se il nostro neurone del senso estetico non fosse affetto da inguaribile narcolessia, non avremmo bisogno di ascoltare in tv geologi che ci spiegano per l’ennesima volta, dopo ogni disastro, l’impossibilità di preservare i nostri beni paesaggistici e culturali (e le nostre stesse vite) continuando a stendere coltri di cemento dappertutto, giorno dopo giorno e anno dopo anno, salvo poi piangere le cose e le esistenze travolte dall’esondazione di fiumi soffocati dal calcestruzzo, da colline che franano per il disboscamento selvaggio, da manufatti abusivi tirati su senza alcun rispetto delle norme, della sicurezza e della stessa decenza.
Il terremoto, lo sappiamo bene e lo ripetono fino alla noia gli esperti, c’entra poco con tutto ciò: il movimento delle placche avviene a profondità tali che quel che l’uomo fa e disfa in superficie gli è totalmente indifferente. E’ la componente “destino” di quel tandem malefico cui abbiamo fatto cenno all’inizio. Su questa componente possiamo influire poco o nulla, almeno per quanto riguarda gli edifici più antichi. Possiamo influire e dobbiamo influire, però, sulle nuove costruzioni, che talvolta crollano inspiegabilmente prima e meglio delle case in pietra dell’ottocento, malgrado sulla carta risultino fabbricate con tutti i crismi imposti oggi dalle leggi e dalla moderna scienza delle costruzioni.
Lì non c’è destino che tenga, lì il Paese si mostra nudo e sghembo al mondo per le precise responsabilità di qualcuno che doveva fare e non ha fatto oppure che ha fatto male, per indolenza, incapacità o furfanteria. Lì, non si scappa, è nolontà o banditismo. O entrambe le cose.
L' ARCHIVIO DELLE RECENSIONI
Anni fa, insieme ai blog dedicati ai miei articoli di politica e costume, avevo aperto un blog di recensioni letterarie. Per me, accanito lettore fin dai calzoni corti (siamo onesti: avere un padre bibliofilo vuol dire trascorrere una infanzia di m.J), “giudicarli”, anche se in veste puramente amatoriale, è stata una esperienza nuova ma molto stimolante. Deposta ormai da tempo la “penna” del critico trepalleunsoldo, intendo però riproporre saltuariamente i contenuti di quel blog in questo spazio telematico, iniziando con la recensione del romanzo di un autore scozzese non molto noto in Italia.
C’è però anche un’altra summa divisio che spesso viene trascurata, ritenendola appannaggio esclusivo delle arti figurative o del cinema: la distinzione tra letteratura d’atmosfera e letteratura di trama. Ci sono scrittori che possono anche non raggiungere vette eccelse per lo spessore culturale della loro produzione , ma che sono ugualmente maestri nel trasportare il lettore in un particolare clima, in una particolare dimensione spaziale o temporale. Accade soprattutto con gli autori di romanzi storici ma non solo. Alexander Mc Call Smith, scrittore americano di origini scozzesi e stimato giurista , è un esempio insuperabile di come si possa proiettare il lettore nel cuore di un mondo lontano anni luce dal proprio, fatto di pudori anglosassoni, di gesti misurati, di dialoghi pieni di non detti, di cieli plumbei, di vecchie strade acciottolate, di muri di pietra e giardini ben curati. Smith ambienta le sue storie tra la buona società scozzese, pregna di intellettuali benestanti che trascorrono oziose giornate visitando gallerie d’arte o bevendo the nei locali caratteristici della vecchia Edimburgo. Uomini e donne che sembrano muoversi dentro una surreale bolla di cocktail, concerti e solidità economica, lontani dalla cruda realtà di una società, quella britannica, dove dietro la patina di perbenismo e buone maniere si agita un proletariato sempre più povero, emarginato e disperato. Eppure i personaggi di Smith, malgrado il loro innegabile snobismo aristocratico e un po’ demodé, risultano per niente fastidiosi : merito certamente dello scrittore, che sa tracciare, dietro le apparenze di vite quiete e quiete docenze universitarie, percorsi umani decisamente meno riparati , recessi bui dell’anima che vengono appena sfiorati, come pozzi neri e profondi dietro le proprie spalle che solo saltuariamente, e per un breve istante, ci si volta a guardare, per poi tornare subito dopo alle certezze appaganti e un po’ ipocrite di una privilegiata quotidianità.
Ma in Smith è soprattutto lo sfondo a far da protagonista, quella Scozia solida, pragmatica e parsimoniosa dove la ricchezza non è vergogna ma neppure fasto pacchiano da ostentare, una terra sospesa nel tempo fra gli orgogli del passato e la lenta, dignitosa decadenza del presente che non rinunzia ai propri riti e alle proprie civettuole reticenze. Un universo parallelo che pare guardare con ironico e placido distacco a tutto ciò che si agita al di fuori di esso, ma con un presentimento di tempesta sempre incombente, uno tsunami annunciato che si spera possa risparmiare, quando e se arriverà, almeno l’illusione della propria contegnosa diversità.
Lavorare stanca è il titolo di una famosa raccolta di poesie di Cesare Pavese. Ma siccome scrivere non è meno stancante quando la carta d'identità ti ricorda che di m...te d'inchiostro negli anni ne hai già sfornate parecchie, da oggi inauguro la rubrica l'Archivio, pubblicando vecchi pezzi scelti però tra quelli che possono ancora avere un loro valenza nella realtà contemporanea.
Novembre 2016
Un eroe italiano
Nel Paese che dedica piazze e statue agli Enrico Toti e ai Pietro Micca, che esibisce come modelli di italianità operosa e vincente manager rampanti, chef alla moda, astronauti, scienziati, calciatori, cantanti lirici, ballerini e militari in missione all’estero, voglio modestamente proporre all’attenzione delle autorità preposte alla concessione delle onorificenze della Repubblica un uomo che – probabilmente – non ha mai messo piede su una astronave, che il militare l’avrà fatto tutto a Cuneo servendo sanbitter allo spaccio, che canta solo sotto la doccia e pure male, che il massimo dell’arte tersicorea per lui è ballare un liscio con la moglie al dopolavoro e che ha problemi pure a friggersi due uova. Quest’uomo “senza qualità” eppur mille volte più eroe di quelli che solitamente amiamo fregiare di questo appellativo si chiama Tindaro Sauta, ha 53 anni e quattro figli e di mestiere fa l’operaio dell’Anas in quel di Lecco. Un cantoniere, insomma. Un semplice cantoniere che avrebbe potuto evitare una tragedia se qualcuno più in alto di lui, qualcuno pagato molto meglio di lui e molto più potente di lui, gli avesse dato ascolto e avesse chiuso quel maledetto tratto della strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga ,km 41,900, dove venerdì 28 ottobre è crollato un cavalcavia che ha schiacciato la macchina e la vita di un professore in pensione.
Nessuno, insomma, ha voluto dar retta all’allarme lanciato da Tindaro Sauta. Che volete che sia l’allarme di un operaio, cosa ne capisce l’operaio di crolli e strade da chiudere. Faccia l’operaio Tindaro Sauta, avranno pensato i soloni soprastanti, il mandarinato amministrativo preposto alle decisioni supreme, la sala dei bottoni insomma. Per chiudere una strada ci vuole la ricognizione di un tecnico che si rechi sul posto e accerti ictu oculi la necessità o meno di interdirla al traffico. Che diamine, sono le procedure di rito e l’ortodossia procedurale è sacra. Chiuderla preventivamente basandosi solo sulla segnalazione di Tindaro Sauta? Incosciente apostasia, perniciosa eresia, devianza eversiva dal Canone del perfetto burocrate, dal Verbo infallibile della circolare, dai Rescritti presidenziali e dalle Bolle dirigenziali. Taccia, dunque, Tindaro Sauta e attenda i responsi degli oracoli spediti dalla Provincia di Lecco, unica Entità dotata di poteri di vita e di morte (è proprio il caso di dirlo) sul tratto di strada che un Tindaro Sauta qualunque pretende di chiudere.
Peccato che i dignitari spediti dalla Provincia non siano arrivati in tempo ad evitare il collasso del cavalcavia e il decesso di un automobilista che in quel momento ci stava passando sotto. Pura fatalità, si saran detti, ma la Regola non si mette in discussione. E’ capitato, che volete farci. Ebbene sì, Tindaro Sauta aveva ragione, ma se dovessimo dar retta ogni volta all’ultimo dei cantonieri…
Invece i Tindaro Sauta andrebbero consultati più spesso in questo Paese. Sogno un mondo in cui insieme a quella del questore, del manager o del dirigente generale ogni tanto si ascolti anche l’opinione dell’agente, della commessa, dell’operaio, del manovale, del fattorino, dell’impiegato. Perché sono questi ultimi che portano avanti, a fatica, la baracca, pubblica o privata che sia, spesso con sapienze e competenze pari o superiori a quelle degli alti papaveri dal conto corrente pieno di zeri.
Paghiamo lo scotto di una pessima filosofia gestionale in auge dai primi anni novanta che ha voluto concentrare attenzioni e prebende sull’attico del condominio invece che sulle sue fondamenta. Da qui l’aumento sconsiderato degli emolumenti alla dirigenza pubblica e privata che ha allargato in modo scandaloso la forbice retributiva tra il vertice e la base. Tutto ciò senza minimamente provare a guardare la “realtà effettuale”, per dirla con messer Nicolò. Una realtà effettuale che vede ogni giorno quadri aziendali o ministeriali supplire alle carenze e alle ignavie di superiori boriosi e strapagati, giudici e procuratori onorari padroneggiare i codici di procedura meglio di tanti magistrati di carriera, tute blu, infermieri e commessi di negozio capaci risolvere rapidamente e validamente problemi anche di non indifferente complessità.
Per costoro niente telecamere, interviste, pubbliche laudi, compensi opulenti. A costoro lo Stato italiano ha riservato invece, a titolo premiale, il blocco ormai quasi decennale dei contratti del settore pubblico o i rachitici aumenti di stipendio di quello privato, la truffa dei voucher e una riforma del mercato del lavoro (il famigerato job act) che forse persino nell’Inghilterra di Dickens avrebbe sollevato qualche sopracciglio.
Ecco perché, sig. Presidente Mattarella, Le chiedo di conferire, a nome di tutti i Tindaro Sauta d’Italia, un solenne riconoscimento al piccolo grande uomo di Lecco. Sarebbe un premio alla silente perizia degli ultimi e un simbolico schiaffo alla stoltezza spaziale dei sommi sacerdoti della Dea Delibera.
CITTADINANZA:VOTERO' SI
MA FORSE SERVIRA' A POCO
L’otto e il nove giugno di quest’anno, tra i cinque quesiti referendari sui quali sarà chiamato a pronunciarsi l’elettorato italiano, il più importante viene comunemente ritenuto, insieme a quello sul cd. Job Act, il quesito che si propone di abbassare da 10 a 5 anni di residenza ininterrotta nel nostro Paese l’età per ottenere la cittadinanza tricolore.
Chi scrive voterà sì all’abrogazione della norma “incriminata”, ossia l’art. 9, comma primo, lettera f, della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, ma ben consapevole, contrariamente a quel che fan credere agli utenti tanti commentatori e uomini politici, che le strade che consentono ad un cittadino straniero di diventare un nostro connazionale resteranno comunque lunghe e piene di ostacoli.
Innanzi tutto va ricordato che in Italia la cittadinanza, quale che sia la via intrapresa per ottenerla, viene concessa con D.P.R., sentito il parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministero dell’Interno, a seguito di una istanza presentata dagli interessati alla Prefettura competente per territorio.
Nel caso di cittadinanza per residenza, come già accennato i presupposti richiesti dal nostro legislatore per ottenere il beneficio in questione, a parte la durata decennale della residenza, sono diversi e li riassumo qui brevemente per chiarire meglio il complessivo quadro normativo della materia.
Oltre ai 10 anni di residenza legale continuativa in Italia (periodo ridotto a 4 anni per coloro che hanno origini familiari italiane, per i coniugati con cittadini italiani e per i cittadini appartenenti a Paesi U.E.), allo straniero che vuole ottenere la cittadinanza italiana si richiede:
1. di essere maggiorenne;
1.di aver superato un esame di italiano che attesti la buona conoscenza della lingua e di possedere un livello ottimale di conoscenza della cultura, delle tradizioni e delle istituzioni italiane;
2. di aver dimostrato conoscenza e rispetto per la Costituzione e i suoi principi fondamentali, le leggi e i valori democratici del nostro Paese;
3. di essere integrato socialmente nella comunità locale di residenza;
4. di essere in possesso di un reddito sufficiente per mantenere sé stessi e i propri familiari (8.263,31 per il singolo richiedente; 11.362,05 con coniuge a carico e aumento di € 516,46 per ogni familiare o figlio a carico). Si prescinde tuttavia dalla sussistenza di tale requisito in caso di matrimonio dello straniero con cittadino italiano; in caso di straniero avente ascendenti italiani; in eccezionali ipotesi di dimostrato bisogno, valutate caso per caso, nonché per l’apolide o il rifugiato stabiliti in Italia da 5 anni. I parametri sono fissati dal Ministero dell’Interno e da quello del Lavoro e delle Politiche sociali;
5.di non avere a carico condanne o procedimenti penali in corso, in Italia o all’estero e neppure contenziosi pendenti col fisco o con la P.A. in genere.
Nel caso di cittadinanza richiesta per matrimonio con cittadino/a italiano/a, oltre agli altri requisiti, la norma richiede che esso deve essere valido per la legge italiana e regolarmente registrato nonché contratto e durato almeno 2 anni prima della domanda di cittadinanza da un richiedente che, in tale periodo, abbia risieduto legalmente in Italia, mentre l’eventuale coniuge straniero deve, a sua volta, essere immune da condanne o precedenti penali in corso, in Italia o all’estero.
Infine, diventa automaticamente cittadino italiano chi nasce da un genitore italiano (c.d. ius sanguinis) e chi viene adottato da genitori italiani; chi nasce da genitori stranieri, abbia compiuto 18 anni e risieduto stabilmente in Italia per almeno 5 anni (c.d. ius soli); lo straniero che abbia prestato servizio per 5 anni per lo Stato italiano.
La documentazione da presentare alla Prefettura, nei casi diversi dall'acquisto automatico del beneficio, è la seguente:
1.certificazione della conoscenza della lingua italiana livello b1 del QCER oppure certificazione di un titolo di studio riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e degli Affari Esteri;
2.permesso di soggiorno o carta di soggiorno lungo soggiornante UE in corso di validità;
3.passaporto internazionale in corso di validità;
4.dichiarazione di non aver commesso reati in Italia o all'estero e di non aver in corso procedimenti penali o condanne in attesa di convalida ;
5.dichiarazione di non avere debiti fiscali pendenti o sanzioni pecuniarie penali (multe), civili (es. per risarcimento danni o per la commissione di illeciti civili, ai sensi del D.Lgs. 7/2016) o amministrative (ammende o infrazioni ex L.689/81) non onorate;
In presenza di tutti i necessari requisiti, a seconda della tipologia di cittadinanza richiesta, dopo gli accertamenti svolti dalla Prefettura e dall’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Interno, in caso di esito positivo dell’istruttoria, consegnerà all’interessato o interessata un codice identificativo (K10) della propria domanda, convocandoli entro 4 anni per il giuramento di fedeltà alla Repubblica, a cui seguirà la proposta del Ministro dell’Interno, sentito il Consiglio di Stato, al Presidente della Repubblica.
Quelli appena descritti sono i presupposti e l’iter della “grammatica” giuridica prevista dal legislatore nazionale per le varie ipotesi d’acquisto, con esito favorevole per i richiedenti, della nostra cittadinanza.
In carenza però di uno qualsiasi dei predetti titoli o situazioni personali o familiari, il Ministro dell’Interno emette un apposito decreto ministeriale di rigetto dell’istanza.
A questo punto l’aspirante alla cittadinanza può avviare la fase contenziosa presso gli organi di giustizia amministrativa, inoltrando un ricorso straordinario al Capo dello Stato oppure un ricorso amministrativo presso il T.A.R. di Roma, a cui può seguire il relativo appello al Consiglio di Stato.
Ma quella appena riportata è solo la descrizione dell’attuale apparato normativo nazionale in materia di cittadinanza (L. 5 febbraio 1992 n.91, D.P.R.12 ottobre 1993 n. 572, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, D.L. 4 ottobre 2018, n.113 convertito in L. n. 132/2018, D.L. 21 ottobre 2020, n.130 convertito in L. n. 173/2020), un impianto legislativo e regolamentare che, come abbiamo visto, enuncia una casistica ben definita di condizioni personali e familiari prodromiche alle diverse tipologie di istanze di concessione della cittadinanza italiana.
Lo scenario tuttavia muta e diventa ben più complesso di quanto già non sia quando il rapporto tra l’aspirante nostro concittadino e lo Stato italiano imbocca la strada del conflitto, del contenzioso giuridico. Qui la casistica delle ipotesi in cui gli organi di giustizia amministrativa hanno ritenuto e continuano a ritenere legittimi i provvedimenti di rigetto della cittadinanza da parte della P.A., con conseguente respingimento dei ricorsi presentati dagli interessati, è molto più numerosa di quella di accoglimento e in base a motivazioni, giustificate dalla natura discrezionale di alcune tipologie del provvedimento concessivo, talvolta parecchio somiglianti, invece, a quelle (giustamente) “prudenziali” solitamente invocate per negare il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni in materia di porto e detenzione d’armi.
Sarebbe sufficiente un breve excursus delle pronunce più recenti emesse già nel corso di quest’anno da parte del T.A.R. Roma e del Consiglio di Stato per renderne conto al lettore, ma glielo evitiamo, limitandoci a ribadire come anche l’abbassamento del numero di anni necessari per la richiesta di cittadinanza per residenza, nella realtà poco potrebbe incidere sugli esiti positivi di larga parte delle future domande di accoglimento.
Lo strano caso delle Due Sicilie
"Sai tu l'isola bella a le cui rive manda Jonio i fragranti ultimi baci..." G. Carducci
Ho visitato di recente il bellissimo abitato siciliano di Piana degli Albanesi, chiamato così perché alla fine del quindicesimo secolo il suo territorio offrì rifugio, insieme ad alcuni comuni calabresi, agli albanesi in fuga dai soldati ottomani del sultano Murad II contro i quali, guidati dal condottiero Giorgio Castriota Skanderbeg, avevano ingaggiato una eroica quanto inutile resistenza.
La mia breve visita a Piana ha confermato ciò che purtroppo penso da anni sui mali della mia Sicilia e dei siciliani e sulle soluzioni da adottare per porvi rimedio.
Piana degli Albanesi è un borgo pulito, ordinato, posto al centro di un territorio dominato da boschi incantevoli e paesaggi mozzafiato nonché per nulla caotico, malgrado il notevole numero di visitatori che vi transitano attratti dalla splendida basilica di rito greco-cattolico di San Demetrio e dal suo famoso lago.
L’incanto tuttavia svanisce quando si attraversa la strada del ritorno e ci si avvicina a Palermo: cassonetti strapieni nelle frazioni ubicate alle porte del capoluogo, immondizia gettata ai bordi della strada e altre delizie del genere umano che risparmio al lettore.
Le due Sicilie, insomma.
La prima, quella d’altura, linda, bella, educata e poco conosciuta.
La seconda, quella di mare, celebrata e nota a tutti e da sempre meta di intensi flussi turistici ma da sempre anche straripante di problemi.
La prima contraddistinta, in genere, da un’attenzione per la tutela ed il recupero dei centri storici, la lotta all’abusivismo edilizio, la cura del decoro urbano e i severi controlli sul rispetto delle regole da parte dei cittadini.
La seconda assediata solitamente da una viabilità caotica e spesso ingestibile, da una bulimia edificatoria che solo negli ultimi anni ha subito una salutare frenata, da gravi carenze nella gestione dei servizi urbani, in primis quello idrico e quello di raccolta dei rifiuti, da diffuse maleducazioni civiche e fenomeni di criminalità predatoria.
Paradigmatica di questa seconda tipologia di realtà abitative isolane, a parte ovviamente i due maggiori capoluoghi di provincia, è Bagheria, la Baaria fenicia, la città di Marianna Ucria, il buen retiro della nobiltà palermitana del XVIII secolo che vi edificò meravigliose dimore gentilizie oggi letteralmente “incarcerate” da raccapriccianti porcherie edilizie (un esempio su tutti: Villa Palagonia, detta “la villa dei mostri” per i famosi e bizzarri elementi decorativi dei suoi spazi interni). Ho citato Bagheria, ma avrei potuto citare altri grossi centri costieri o di pianura come Gela o Vittoria: le problematiche sono identiche o quasi (se non peggiori...).
Perché queste differenze di ordine e decenza tra borghi d’altura e borghi marittimi?
Premesso che esistono in Sicilia anche centri rivieraschi o di pianura che nulla hanno da invidiare a quelli d’altura e viceversa, le differenze per tutti gli altri si chiamano: un parco nazionale (il Parco dell’Etna), 4 parchi regionali e 75 riserve naturali.
Nelle aree vigilate in Sicilia dai parchi e dalla riserve, compresi i centri abitati che vi ricadono, esistono infatti regole rigidissime e controlli severi sul rispetto delle norme poste a tutela dell’habitat umano e ambientale; nelle altre parti del territorio regionale, ove gli stessi obblighi di vigilanza e repressione spettano ai comuni o ad altri organismi, non sarà raro invece riscontrare gravi inefficienze, negligenze od omissioni.
La morale di tutto questo è una conferma che la Sicilia, come intitolò Leonardo Sciascia un suo celebre saggio, è metafora del mondo, una replica in “formato tascabile” di tutto l’ottimo e di tutto il pessimo del pianeta.
Detta in parole povere, c’è la Sicilia da pollice alzato e quella da pollice verso, quella dell' hombre vertical, più inflessibile di un piemontese e indisponibile a qualsiasi compromesso su leggi e precetti del vivere civile, e quella dell' hombre horizontal, del bardo del “chi mi ni futti” (cosa mi interessa…), del siciliano con la casa più pulita di un ospedale svizzero ma con l’immondizia puntualmente abbandonata al primo angolo di strada a disposizione.
E’ quest’ultima progenie di siciliano la categoria sociale dominante nella Trinacria cd. “zerbinista”, ossia preda di una concezione bacata della res publica secondo la quale lo Stato finisce dopo il tappeto d’ingresso della propria abitazione e ciò che accade oltre non è faccenda che interessi e coinvolga il proprietario e i suoi familiari.
Questa concezione "malata" della cosa pubblica è figlia della Storia: il lungo dominio spagnolo è stato un potere che - fatta eccezione per l’esazione delle gabelle e per l’ordine pubblico - se n’è fregato bellamente del controllo e della gestione del territorio, abbandonandolo così alla mercé di nobilastri d’ogni genere (credo non ci sia zona d’Italia che possa vantare più conti, baroni, duchi, marchesi e principi della Sicilia: ogni nuova dominazione ne nominava a iosa tra i favoriti del conquistatore di turno), i quali a loro volta sorvegliavano, vessavano e taglieggiavano i contadini schiavizzati dei loro immensi latifondi attraverso i tanti tagliagole a libro paga (gli antenati dei mafiosi odierni). I Borbone (peraltro anch’essi d’origine iberica) non hanno cambiato una virgola di questo modo di governare mentre i loro successori Savoia hanno preferito non entrare in conflitto con quei maggiorenti locali - in genere di estrazione altoborghese ma reazionari, avidi e rapaci anche più degli aristocratici che avevano scalzato dal vertice della piramide economica - i quali, passata la paura di esiziali sovvertimenti sociali generata dallo sbarco dei Mille, tanto si erano spesi per un ingresso indolore della Sicilia nel nascente Regno d’Italia.
Il risultato è stato che, mentre i sudditi del Piemonte sabaudo, della Repubblica di Venezia, del Ducato di Toscana e persino del Papa Re hanno avuto governanti e civil servants degni di questo nome, il Meridione e la Sicilia hanno avuto solo una lunga teoria di cacicchi e balivi, ognuno dei quali padrone assoluto o quasi a casa propria, con i riflessi che si possono immaginare sul mos maiorum dei meridionali e dei siciliani in particolare, in virtù della loro insularità: individualismo esasperato e indifferenza verso tutto ciò che esula dalla sfera personale, familiare o amicale.
Invertire questa rotta, in quella parte della popolazione siciliana tuttora adiaforica verso i valori dell’“accudimento” e della tutela di ciò che appartiene all’intera comunità, non è affatto facile e forse solo un lungo e serrato impegno in tal senso da parte delle pubbliche istituzioni potrebbe coltivare, nel lungo periodo, una qualche speranza di successo. Tuttavia provarci è un dovere, prima ancora che una necessità: la terra di Gorgia ed Empedocle, Archimede, Antonello da Messina, Juvarra, Bellini, Verga, Pirandello, Brancati, Sciascia, Quasimodo, Vittorini e Majorana, non merita di rischiar di lasciare, negli occhi di un turista che riattraversa lo Stretto, in mezzo alla tanta bellezza anche l’immagine di un imbecille che getta il proprio pattume da una macchina in corsa.
P.S. Ad onor del vero, però, che siano vertical o horizontal, la maggior parte dei siciliani tre pregi li ha sempre avuti e continua ad averli: la generosità, l'ospitatilità e la pietas, la sincera e partecipata empatia verso il dolore e la sofferenza altrui. Non è poco, nell'attuale temperie che sta attraversando l'umanità...
Miss Europa e le allegre comari di Piazza del Popolo
“Ma che cosa sono le leggi, illustre rappresentante del P.M., se non esse stesse ‘correnti di pensiero’? Se non fossero questo, non sarebbero che carta morta... “
Piero Calamandrei, giurista, avvocato e deputato socialista, 1957
Per la premier l’Europa di Ventotene non è la sua Europa. E bon, ce ne faremo una ragione. Non vedo il motivo di rovinarsi l’ugola, come stanno facendo da un paio di giorni i parlamentari dell’opposizione, per frasi dal sen fuggite tese solo a ribadire che lei con certi passi del Manifesto, tra cui ad esempio quello nel quale si invoca una rivoluzione socialista in Europa, non ha niente da spartire.
Sai la novità: è di destra, è cresciuta nell’MSI di Almirante, nel corso del tempo ha provato, seppur tra balbettamenti, silenzi, distinguo e acrobazie verbali, a riciclarsi come democratica e antifascista ma, gratta gratta, la “punzonatura” è quella. Come si può pretendere che le piaccia la”rivoluzione socialista”? “Chi nasce rotondo non muore quadrato” si dice dalle mie parti e questo può valere per la stragrande maggioranza dei politici, ma non solo: provate a far dire ad un comunista trinariciuto della “vecchia guardia”, ma che da anni ormai in pubblico fa professione di sincera socialdemocrazia, che il regime sovietico è stato solo il dominio di una oligarchia burocratico-militare ottusa e feroce e vi arriverà, rompendo il muro del suono, una sfanculata megalattica.
Tutto ciò però i politici italiani del centro-sinistra lo sanno bene e se strepitano ad ogni peto silente e inodore dei loro colleghi della maggioranza è perché oggi la politica, qualunque sia la maglia che indossi, non si fa con gli argomenti, si fa con gli schiamazzi fini a se stessi. A parti invertite non cambierebbe nulla, ma questo è un fattore, figlio della dialettica parlamentare trepalleunsoldo in auge in Italia da oltre un trentennio, che se per l’elettorato italiano di destra o per i simpatizzanti della sinistra cd. “antagonista” ha ben poca importanza, abituati entrambi come sono – dopo Mussolini e Berlusconi l’uno e dopo gli anni settanta gli altri – a vivere la politica per slogan urlati, frasi fatte e semplificazioni da asilo mariuccia, per la sinistra riformista rappresenta invece il preoccupante termometro di una involuzione e di uno scadimento profondi del suo linguaggio e della sua azione.
Ora, sulla seconda forse c’è ormai ben poco da fare, visto che i precedenti nove - dicasi nove - governi di centro-sinistra che abbiamo avuto dalla fine degli anni novanta ad oggi, si sono distinti, ad onta del nome, più per le politiche liberiste e i tagli alla spesa sociale che per altro, rompendo così, forse in maniera irreversibile, il cordone ombelicale con il loro elettorato di riferimento (la cartina al tornasole di quanto sopra è oggi un partito post-fascista al 30%), ma sul linguaggio ci sarebbe ancora tempo per recuperare una parte del predetto cordone ripristinando una tradizione fatta di politici pacati ma fermi, opimi di cultura e competenza, intransigenti nella difesa dei loro valori ma che di rado, e quasi sempre a ragion veduta e per il tempo strettamente necessario, alzavano il volume delle corde vocali.
Perché poi il problema non è solo “estetico” ma anche di “comprensione del testo”, oserei dire: le parole, si sa, “sono pietre” ma quando vengono scagliate alla pene di cane rischiano di confondere e smarrire coloro che le ascoltano, inducendo ad esempio “er glorioso popolo democratico e desinistra” ad organizzare una manifestazione oceanica a favore della UE, con balli, canti, sventolio di bandiere, discorsi appassionati dal palco, sfilata di esponenti della politica ,dello spettacolo e della migliore intellighentia progressista nonché di tutto il caravanserraglio che solitamente transuma per le strade in queste circostanze.
Tutto molto bello, molto emozionante, coinvolgente e commovente.
Ma fuori luogo.
L’Europa attaccata dalla Meloni, se dobbiamo attenerci strettamente alle sue parole, è solo quella di due dei tre “genitori” del Manifesto di Ventotene, ossia di Altiero Spinelli, comunista, e di Eugenio Colorni, socialista ( l’ultimo della “sacra triade”, ossia Ernesto Rossi, era liberale). Quella, cioè, che sognava la già citata “rivoluzione socialista” e l’avvento di un regime molto simile a quello sovietico: “La rivoluzione europea dovrà essere socialista”; “…la proprietà privata dovrà essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”; “…attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma il nuovo Stato”.
Niente a che vedere , quindi, con la UE turboliberista, e ora pure turbomilitarista, nata a Maastricht dopo la Caduta del Muro: vestale del Dio Mercato, consorteria gaudiosa di alta finanza, politica corriva e imprenditoria di rapina, affamatrice dei popoli dell’ovest, sfruttatrice di quelli dell’est e Moloch famelico molto poco democratico, con un Parlamento buono solo a foraggiare lautamente i suoi membri - ma che in pratica conta nulla o quasi - ed una Commissione, vera tolda di comando della baracca, che nessuno può sfiduciare e che i soldi che non vuole spendere o far spendere in welfare e servizi, miracolosamente li trova per fabbricare missili, bombe, aerei da combattimento e carri armati.
E’ per questa UE che è sceso in strada a Roma “er glorioso popolo”? Per metà sì e per metà no. L’altra metà, che “er glorioso popolo” lo schifa (diciamo le cose come stanno), era composta da politici e simpatizzanti di quegli stessi partiti di centro consguardoadestra (ogni riferimento a Renzi o a PiùEuropa è puramente casuale…) che attualmente stanno all’opposizione e i cui membri preferirebbero soffrire di dissenteria per sei mesi di seguito piuttosto che veder salire al potere, in Italia e in Europa, movimenti politici autenticamente di sinistra, portatori ed esecutori di programmi autenticamente di sinistra.
E dunque? Non avevano capito bene contro chi, con chi e per cosa si doveva manifestare? Ci sono stati errori di comunicazione, come nella sciagurata carica della cavalleria britannica a Balaklava? No, semplicemente c’è stato un fraintendimento: alla Meloni non piace l’Europa di Spinelli ma quella di Orban siamo certi che le piace da morire, invece partiti ed elettori del PD e “isole comprese”, a partire dal promotore Serra, hanno capito che lei era “contro la (Dea) Europa” tout court. E così la frittata è stata servita. Anzi, come scrive oggi sul F.Q. il portavoce di Potere al Popolo Giuliano Granato prendendo in prestito un’espressione del giornalismo d’oltre Manica, l’aringa - intesa come “arma di distrazione” da altre questioni ben più importanti e imbarazzanti - è stata servita e i deputati dell’opposizione, more solito, ci sono cascati. Urlatori e pure babbioni, insomma.
Ora vallo a dire fra un paio di lustri ai figli o ai nipoti che un giorno di tanti anni fa hai marciato, fiero ed entusiasta, a fianco di eroici europatrioti come Matteo Renzi, padre spirituale di quel sublime capolavoro di precarietà pro padronato noto come Job Act.
Articolo datato ma - ritengo - con alcuni spunti sempre attuali
SALVIAMO IL SOLDATO GIULI
Una volta pensavo a Giuli e la mente mi rimandava l’immagine di un garbato, colto ed elegante giornalista di destra nonché Presidente della Fondazione Maxxi; oggi penso a Giuli e la mente mi rimanda l’immagine di un Des Esseintes fuori tempo massimo o del Dott. Dieu (definizione di Sarah Bernhardt) in vestaglia rossa, ossia del medico italo-francese Samuel – Jean Pozzi, immortalato in un famoso quadro del pittore americano di fine ottocento John Singer Sargent nonché celebrato, insieme ad altri protagonisti della Bella Epoque, in un recente romanzo dello scrittore inglese Julian Barnes, l’ autore del ben più noto Livelli di vita.
Oggi Giuli per me, ma non solo, è pertanto sinonimo di fumisterie oratorie, comunicazione involuta, periodare barocco infarcito di vocaboli ampollosi, metafore ardite, allegorie ermetiche.
Da ultimo il nostro eroe, non sazio delle (in fondo) benevoli “pernacchie” ricevute dopo le sue precedenti, dotte e indecifrabili prolusioni, pare persino che abbia scoperto l’acqua come principio primigenio del Creato, peccato però che ci fosse già arrivato un certo Talete nel VI secolo A.C…
Il risultato di tanta produzione ad alto tasso di erudizione è che, dopo un profluvio di discorsi eccessivamente forbiti - quando non totalmente criptici e talvolta impossibili da interpretare persino per la Pizia del Santuario di Delfi - atteggiamenti mollemente decadenti, pause talvolta imbarazzanti e comunque sempre prodromiche all’ennesima perla linguistica in caldeo, Giuli, bardo della destra digeribile, politicamente corretta e biodegradabile, l’amico stimato di tanti colleghi e politici di sinistra, in poco tempo si sta giocando tutto l’ apprezzamento e il rispetto di avversari ed elettori e per motivi che, francamente, più che misteriosi sembrano sortiti da un personalissimo ed irrefrenabile cupio dissolvi, probabile figlio legittimo, oltre che dell’affaire Spano (polpetta avvelenata di sangiuliani, omofobi, neanderthal Pro Vita e nostalgici del braccino teso), del suo ingresso, in qualità di Ministro della Cultura, nel brodo primordiale della politica nazionale, una pentola in eterna ebollizione che scioglie impietosamente chiunque, da debuttante “puro di spirito”, si affacci per la prima volta sul suo proscenio.
In effetti, a ben guardarlo, il caravanserraglio politico a cui appartiene Giuli abbonda da sempre di iene e tigri, più che di pacifici ruminanti. Iene e tigri per giunta molto meno stilisticamente eleganti dell’altra sponda politica, zeppa però, a sua volta, di fighetti benpensanti e regolarmente muniti di patenti vidimate di democrazia, ma finora buoni solo a lamentarsi con l’attuale maggioranza per mancate e sacrosante riforme sociali che avrebbero dovuto varare loro in tutti gli anni in cui sono stati in groppa al cavallo governativo (un esempio su tutti: la patrimoniale, riforma che la Schlein ora pretende dalla destra dopo che gli esecutivi di centro-sinistra l’han sempre sdegnata) , forse anche perché troppo impegnati nel patrocinio dell’accoglienza (un valore del cristianesimo) e dei diritti LGBTQ+ (un valore del liberalismo illuminato). Ma si sa, quando non puoi o non vuoi più farti paladino di una causa, come nel mercato l’imprenditore rivolge la sua attenzione al prodotto di tendenza, nella politica i partiti si gettano nella difesa del valore di tendenza…
In ogni caso, lo spessore ectoplasmatico dell’opposizione non invalida l’ininficiabile postulato che descrive da anni i politici del centro-destra nazionale come un branco di affamati elefanti in cristalleria, insuperabili nel saper affettare, con piglio degno dei pizzicagnoli trasteverini, il grasso colante delle politiche interne, peraltro conformemente ai desiderata del ventre molle dell’elettorato moderato, in gran parte refrattario a spiegazioni complesse e arzigogolate dei problemi del Paese e delle loro possibili soluzioni.
In tutto questo il buon Giuli, autentica “barca nel bosco”, per citare la bravissima Paola Mastrocola, non ha trovato di meglio che rifugiarsi nel fraseggio esoterico, iniziatico, dei suoi interventi, un po’ per distinguersi, dannunzianamente, dal resto dei suoi colleghi (“come puteano questi barbari…”) e un po’ per far credere di essere posseduto dall’LSD o da qualche entità aliena.
Insomma, una via di fuga alla Amleto e un raffinato perculamento per far credere ai gonzi - amici e nemici - che lui non è più compos sui, almeno fino a quando non deciderà di tornare ad essere il Giuli politicamente corretto e, soprattutto, comprensibile di prima o fino a quando il suo dannunzianesimo postmoderno non sarà digerito dalla platea e dal palco della politica nazionale, perché se crede che la Meloni, come fece Mussolini col Vate, gli regali un nuovo Vittoriale degli italiani, spiace deluderlo nonché metterlo in guardia: la leader di FdI, viste le attuali inopie di Cassa, al massimo potrà permettersi di incollargli dietro al deretano un’altra giovane ed affascinante infermiera pericolosamente simile a quella tedesca da sempre sospettata, dalla vox populi, di essere stata l’avvelenatrice dell’Immaginifico, notoriamente avverso all’alleanza dell’Italia con Hitler ed il nazismo.
Ci pensi soldato Giuli, inizi le manovre di atterraggio e rientri al più presto nel recinto dell’umano consorzio.